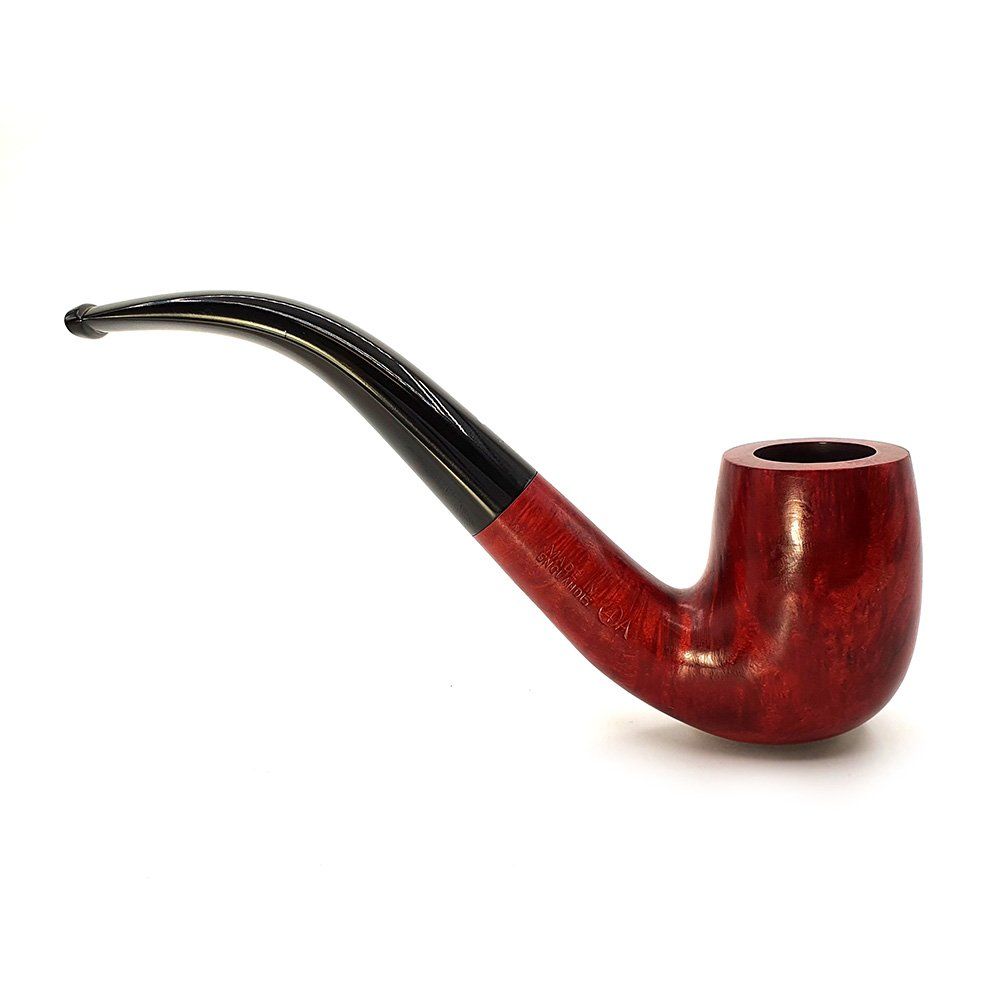Sua Maestà
This is a subtitle for your new post

Sigareide
Un sigaro e una croce di cavaliere non si negano a nessuno. Era un motto pacioccone dell’Italia umbertina, poi vennero altri motti, meno paciocconi, e altre croci. Gli italiani non sono grandi fumatori di sigari, con un discorso tutto a parte per i Toscani, gloria delle nostre manifatture. Ma andiamo con ordine.
Si parte sempre da Colombo. La parola sigaro deriva dallo spagnolo cigarro che , a sua volta, deriva da un sacco di cose. Sicar, dicono alcuni, era l’involucro che i Maya usavano per avvolgere il tabacco. Perché andare tanto lontano, ribattono altri, quando cigarar, e proprio in spagnolo, significa arrotolare. Ma lo spagnolo ha anche cigarra, cioè la cicala, ed è evidentissimo – sostengono altri ancora – che la forma del sigaro è simile a quella della cicala. Ci sono naturalmente altre fantasie etimologiche, compresa una che si rifà a un’antica lingua parlata nelle Antille, ma sembra il caso di fermarsi qui. Logico, d’altra parte, che il nome sia spagnolo: Rodrigo de Jerez il 28 ottobre 1492 o Vincent Pinzon il 5 novembre (marinai di Colombo) videro gli indigeni della nuova terra da loro scoperta portare alla bocca e fumare una specie di fagotto di foglie secche (controverso se fosse tutto tabacco o se l’involucro fosse il mais). Lasciamo perdere quelle lontane scoperte, lasciamo perdere anche la leggenda che, tornato in patria, Rodrigo de Jerez sia stato imprigionato per dieci anni proprio per aver fumato in pubblico quei “fagotti”. In realtà sigari veri e propri fanno la loro apparizione molto più tardi, quando già il tabacco ha un posto ben preciso nella medicina e nei vizi umani: lo si fiuta, lo si mastica, lo si fuma in pipe di vari materiali.
Gli storici della materia stabiliscono nel 1731, a Siviglia, la nascita ufficiale del sigaro. Veramente, risulta che nella città spagnola si facevano sigari da almeno cinquant’anni, ma è del 1731 la creazione delle manifatture reali. Siviglia, le sigaraie, Carmen, ecco dunque che tutto si spiega. Il romanticume dell’800 trasforma in “fiori di passione” povere operaie dannate a un lavoro duro e malsano; e regala al sigaro una carica sessuale, erotica, ancora tutta da dimostrare. La faccenda è vecchia e dura a morire: le sigaraie (non solo a Siviglia ma anche a Cuba) facevano i sigari arrotolando il tabacco sulle loro cosce nude. Era il modo migliore – dicono – per dare la giusta curvatura all’involucro.
Sulle cosce nude hanno favoleggiato in parecchi ma, chiusa la parentesi erotica, torniamo alla storia. I rapporti tra Spagna, Portogallo e Paesi Bassi fanno sì che gli Olandesi, verso la fine del ‘700, si mettono a fabbricare sigari e questi ultimi, essendo padroni delle Indie Orientali, saranno poi i primi ad usare tabacchi di Giava e Sumatra al posto di quelli tradizionali delle Indie Occidentali. I francesi conoscono il sigaro per la prima volta nel 1793 quando un corsaro cattura una nave olandese che viene dall’Avana, ma solo nel 1816 il loro nuovo monopolio glieli offre ufficialmente. E’ di un anno prima la nascita del Toscano in Italia. Pare che i tedeschi, diventati in seguito grandi consumatori, abbiano conosciuto il sigaro in Italia, dove si era introdotto attraverso il porto di Napoli. La prima fabbrica di sigari in Germania è del 1788 ad Amburgo. Più o meno nella stessa epoca cominciano anche i danesi: alla fine dell’800 funzionano più di cento manifatture in Danimarca, che poi vanterà il consumo di sigari pro capite più alto al mondo.
Alla nostra storia – e sia pura a quella minore – appartengono alcune vicende note. Nel Lombardo Veneto, a differenza di altri paesi, gli austriaci avevano dato il permesso di fumare nelle strade, permesso esteso nel 1847 anche ai soldati in uniforme. I sigari più diffusi erano i “Virginia”, prodotti dal monopolio austriaco, e i milanesi a un certo punto decisero di non fumarli più, preferendo i piemontesi “Cavour”, per dispetto e per ridurre le entrate di quel monopolio. Ci fu la caccia al sigaro e si verificarono scontri e vittime, anche in episodi simili a Pavia, Padova e Venezia. Cleto Arrighi (scrittore della Scapigliatura milanese) riferisce nelle sue “Memorie di un ex repubblicano” di un atto di pubblica sfida nei confronti di militari austriaci in cui, ad una cena dell’ultimo dell’anno del 1858, i convitati, allo scoccare della mezzanotte, spezzarono e gettarono i sigari Virginia che stavano fumando, per accendere i Cavour “fra il tintinnio dei calici spumanti, e i brindisi al ministro, s’avviarono processionalmente in giardino, dove in apposita fossa, a lume spento, vennero sepolti i pezzi di Virginia fra le risa e le facezie di quei Buontemponi”. “Gli ufficiali austriaci cominciarono ad aver paura ed usar prudenza”.
Anche il sigaro dunque ebbe la sua piccola parte nell’indipendenza dell’Italia. –Segue –
Smoking numero 4 anno sesto, 1980